C’è qualcosa di prodigioso e al tempo stesso disumano nel cavallo che si presenta un giorno fuori dalla baracca in cui Al ha deciso di ritirarsi e vivere quel che gli resta da vivere. In solitudine, sì: in una ex-concessione mineraria nel Nevada, con una scorta di zuppe Campbell, una tuta termica per sopportare meglio il gelo invernale, un’automobile dalla batteria esausta, e dentro di sé un vaso di pandora pieno di demoni da un passato che a stento riesce a mettere a tacere.
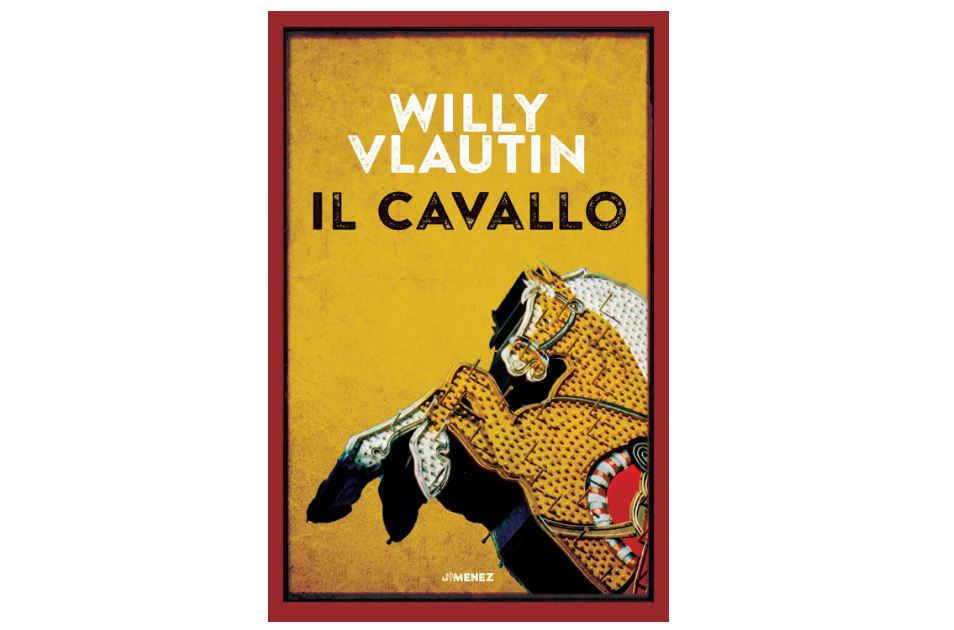
All’improvviso, dal niente, in mezzo a quel niente, un cavallo. Con gli occhi malati, probabilmente cieco. Se ne sta immobile, nel gelo. Non mangia. Non vuole saperne di andarsene. È prodigioso il suo apparire, ed è disumano il suo esserci nella misura in cui si propone ad Al come presenza chiusa in se stessa, priva di qualunque appiglio comunicativo. Un enigma in forma di bestia. Ostinata e inerme. Al è colpito, soggiogato da quel mistero così evidentemente privo di misteri: non è che un cavallo, probabilmente fuggito, o abbandonato. Sente di doverlo proteggere, lo difende dall’aggressione dei coyote, tenta di nutrirlo (inutilmente). L’equilibrio che lo teneva irrigidito nella sua solitudine inerte, si spezza. L’isolamento che indossava come una corazza, si dissolve. E la memoria rompe gli argini, torna a chiedere conto, a far pulsare le cicatrici.
Willy Vlautin non ha interrotto la sua attività di musicista: dopo che si è conclusa l’avventura degli ottimi Richmond Fontaine, ha proseguito nei collaterali The Delines, quintetto con già sei album in repertorio. Però nel frattempo Vlautin è diventato a tutti gli effetti un romanziere: Il cavallo, pubblicato in Italia da Jimenez (addirittura prima dell’uscita statunitense per Harper Collins), è il suo settimo romanzo dal 2006, anno in cui vide la luce l’indimenticabile The Motel Life. Ed è uno dei suoi lavori migliori, nonché quello in cui intravedi con più nitidezza riverberi autobiografici.
Al infatti è un musicista. Anzi, meglio: lo è stato. Per inciso, una domanda attraversa come una vibrazione sorda tutta la vicenda: si può smettere davvero di esserlo? A sessantacinque anni, con un passato di scelte sbagliate, vicoli ciechi, frustrazioni, lo spirito e il corpo danneggiato da un alcolismo che ha preso progressivamente il sopravvento, Al ha deciso di chiudere i ponti. Approfitta della baracca nella concessione mineraria ricevuta in eredità, e toglie il disturbo. Niente più Reno, niente più concerti, niente più canzoni scritte come se non potesse fare altro che decifrare la vita – appunto – una canzone dopo l’altra. Ma senza poterle cantare, perché la sua voce “non serviva a niente se non a spiegare una canzone“.
Mentre Al sente, senza spiegarselo, di non poter fare altro che prendersi cura di quel cavallo comparso dal niente, anche se “prendersi cura” dovesse significare uccidere la bestia, evitargli sofferenze ulteriori, mentre si dibatte tra questo dover fare inatteso, i flashback arrivano come onde lunghe, con l’impeto quieto degli accadimenti che hanno emesso sentenze inappellabili. Sul tavolo inizia così a cadere una pioggia di carte perdenti, in ognuna la scintilla di ciò che è stato e la cenere di quello che avrebbe potuto essere.
Al, appunto, suonava la chitarra – soprattutto la sua Telecaster butterscotch-blonde del 1959 – e scriveva canzoni. Nel ricordo, enumera grappoli di titoli che già di per sé presuppongono sguardi sullo stare al mondo in quella parte di mondo, iceberg narrativi di cui affiora solo una parte minima. Ad esempio: “The Killing of a Motel Maid, A Drink Before Work, Waking Up Outside of Bruno’s, The Le Mans, Waiting for You to Get Off Work, I Hope You Don’t Ever Have to See Me This Way, Nancy and the Pensacola Pimp, The Used-Car Lot, Little Leon and Josie the Junkie…” e via discorrendo. Canzoni che intrigano musicisti in cerca di autori, i quali ingaggiano Al per la sua abilità di chitarrista ma soprattutto perché ottimo compositore, capace di far brillare e rendere preziosa la tristezza di una canzone. Con gli ingaggi nelle band arrivano i concerti, serate su serate nei casinò di Las Vegas e Winnemucca, oppure tour sfiancanti in piccoli club con una band cowpunk in cui per la prima volta sente di credere. E si innamora, Al. Ricambiato.
Maxine aveva occhi nocciola e capelli rossi che le arrivavano alle spalle, e la sua pelle era lentigginosa e pallida. Indossava pantaloni neri e camicetta bianca con sopra un grembiule nero legato in vita. In lei c’era una tristezza che Al percepì dal primo momento in cui la vide. Era come se vivesse la sua vita zoppicando leggermente, portandosi dietro una frattura che non riusciva a riparare. Per lui era bella, perché aveva un aspetto un po’ sbattuto. Aveva un umorismo nero e una faccia che diceva: Puoi anche vincere ogni volta, ma non avrai mai tutto.
Tuttavia, la carta perdente è sempre lì, in attesa che la peschi dal mazzo. Ci sono sempre ingranaggi che non s’incastrano e relazioni che all’apparenza mettono a posto più cose di quante non ne danneggino, ma sembra soltanto.
Per Vlautin il loser non è solo un’angolazione che porta in dote una cassetta degli attrezzi, è una vera e propria condizione esistenziale che al tempo stesso sa farsi epocale, una chiave per decifrare la natura profonda del vivere ma anche per gettare luce sullo stato di abbandono al cuore del sistema sociale dominante, in cui la reciprocità viene demolita sciogliendo un nodo alla volta, tirando via strati progressivi di empatia e comprensione, fino a lasciare la carne nuda, vulnerabile.

Il cavallo rivela il lato più malinconico di Vlautin, quel disarmo che incrocia spesso le armi con uno scollamento tossico dall’equilibrio (come può esserci equilibrio se coincide con una resa alla trama della mediocrità?), in una scrittura crepuscolare e dalla spietata asciuttezza, come se Kent Haruf e Cormac McCarthy si fossero dati appuntamento a metà strada a discorrere di anime sul punto di smarrirsi, nei molti modi in cui un’anima può farlo.
Aveva chiuso con musica, con la scrittura di canzoni che nessuno ascoltava, con i concerti inutili in locali inutili dove la gente voleva solo parlare e bere. Aveva finito di svegliarsi nel cuore della notte per buttare giù i testi che gli venivano in mente. Aveva finito di rimuginare sulle canzoni fino a diventare mezzo matto. E per quanto ci provasse in tutti i modi, le sue canzoni erano buone ma non erano mai ottime. Quanti taccuini aveva riempito di canzoni passabili,canzoni che erano “quasi”? Per quante ore e quanti mesi e quanti anni aveva sgobbato? E Cristo, quante ore aveva sprecato a imparare cover di canzoni che odiava? E perché la gente chiedeva sempre canzoni orribili? E perché le canzoni che lui amava di più non erano mai famose?